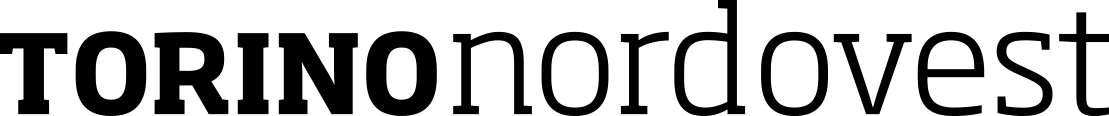Stefano Micelli
/Data
2/2013
/Titolo
L'artigiano digitale
/Autore
Alberto Papuzzi
/Risorse
/Tag
innovazione, lavoro, makers, tecnologia
/Condividi
Stefano Micelli, docente di International management all’Università di Cà Foscari di Venezia, ha scritto un libro il cui titolo, Futuro artigiano, si presta a una doppia interpretazione, che è la chiave di lettura del saggio: da un lato ci dice che il nostro futuro – nostro, delle imprese, della produzione, dello sviluppo, ma persino della democrazia – avrà il carattere del lavoro artigiano, dall’altra ci annuncia che intende spiegarci come sarà l’artigiano del futuro, come sia destinata a mutare questa figura fondamentale della realtà economica italiana.

Professor Micelli, industria e artigianato, nel nostro paese, sono state storicamente due realtà contrapposte, sebbene una larga parte dell’artigianato si potesse reggere alle dipendenze dell’industria. Per citare due situazioni emblematiche abbiamo avuto da una parte la grande produzione concentrata nel triangolo industriale, dall’altra la fioritura e il successo della piccola impresa nel Nordest. Ma nel suo libro Futuro artigiano lei sostiene che lo sviluppo industriale italiano ha bisogno di incorporare la cultura dell’artigianato e prospetta come soggetto leader del nostro sistema industriale la nuova media impresa italiana. Che cosa significa sul piano pratico? Come suonano queste nozze fra industria e artigianato?
«I punti di vista sulla questione possono essere diversi. Abbiamo un punto di vista come dire pubblico, legato a quella che una volta chiamavamo politica industriale: oggi il termine è considerato desueto, ma di fatto ha ancora una sua validità. Abbiamo il punto di vista del management, che deve porsi la domanda su quali siano le ricette vincenti per le singole imprese e non per il paese nel suo complesso. C’è un terzo punto di vista, quello del singolo lavoratore che si chiede: cosa devo fare io per lavorare in un momento in cui le competenze che mi sono richieste sono in rapido cambiamento? Credo sia utile renderci conto che molte cose sono cambiate negli ultimi anni, esiste oggi uno scenario in cui l’Italia deve rapidamente trovare una sua posizione nei processi di divisione internazionale del lavoro.
Il ventaglio delle opportunità che abbiamo di fronte non è all’infinito, non possiamo più genericamente decidere cosa fare: il mondo in qualche modo decide anche per noi e ci assegna un valore, dichiara interesse per alcune delle attività che facciamo, mentre per altre dimostra un certo disinteresse, non è poi così entusiasta rispetto a alcune produzioni e alcuni servizi di pubblica utilità, mentre altre attività incontrano sui mercati internazionali un grande favore. Se guardiamo agli ultimi dieci anni c’è poco da fare: la media impresa italiana che ha caratterizzato il Made in Italy, cuore di un’area artigianale nel sistema, è riuscita a diventare protagonista di un’offerta che il mondo riconosce come un’offerta di valore. Su questo direi che possiamo auspicare decine di multinazionali italiane, che operino sul mercato globale, magari con prodotti high tech, però nel breve e nel medio termine ci tocca fare con quel che abbiamo».
Quali sono i problemi che rendono complicato il rapporto fra industria e artigianato e rallentano il processo di crescita che lei ha messo a fuoco?
«Vorrei dire che siamo vittime, noi italiani, di una sudditanza culturale: appena abbiamo visto delle aziende crescere magari proponendo specifici prodotti su misura, subito le abbiamo battezzate come multinazionali, cercando di esorcizzare ogni possibile anomalia. Dicendo: sono come le multinazionali americane, soltanto un po’ più piccole. Questo è quello che abbiamo fatto con il dibattito degli ultimi dieci anni. In realtà se noi le prendiamo da vicino, queste medie imprese italiane altro non sono che un esperimento riuscitissimo di managerializzazione di saperi che non potevano più, in alcun modo, continuare a sopravvivere dentro strutture troppo piccole, e che avevano bisogno per essere valorizzati di un loro management particolare, il management della media impresa che abbiamo sotto il naso. Oggi il mondo intero riconosce il valore di questo saper fare, lo riconoscono in America, lo riconoscono in Francia, direi che il modello è ormai acclarato.
Quindi gente come me, che insegna management ai ragazzi, deve dirgli: vabbè, dobbiamo pensare a un modello d’impresa che, invece di dichiarare obsoleto a priori un saper fare che è parte fondativa del vantaggio competitivo delle nostre medie imprese, lo incorpora e lo fa diventare un elemento di specificità, e su questo costruisce ovviamente un piatto – la comunicazione, la distribuzione, il rapporto con i fornitori, eccetera eccetera. In pratica tutto questo ha già preso forma, tuttavia manca la parte teorica, manca una riflessione di tipo astratto, che peraltro è molto importante per un preciso, particolare motivo, cioè per la riscoperta che tutto il mondo sta facendo del lavoro artigiano».
Ma questo implica anche un ritorno al passato, significa cioè il ritorno ai mestieri d’una volta?
«No. Non dobbiamo in alcun modo dire ai nostri giovani di tornare ai mestieri d’una volta. I mestieri d’una volta sono passati, ahimé il tempo che è passato non ritorna. Quello che invece dobbiamo proporre è di riconciliarci con il nostro saper fare, che opportunamente mescolato per esempio con i nuovi mezzi di comunicazione, o con le nuove tecnologie, o con la tecnicalità della rete, può diventare qualcosa di davvero unico e interessante».
Disegnato questo quadro, si aprono molti interrogativi. Per esempio lei considera e valuta diverse forme di lavoro artigiano e mette a fuoco una distinzione, delle differenze, fra il lavoratore artigiano secondo tradizione, che so, per esempio, il tornitore o lo stampista, e i maestri d’arte. Lei racconta la storia di Lino Tagliapietra, uno dei grandi maestri del vetro soffiato muranese, che inizia a lavorare in fornace da bambino e arriva a insegnare nelle scuole americane. Allora, le domando: il ruolo dei maestri d’arte, il gusto artistico o le competenze nel design quanto pesano nel lavoro artigianale?
«Proviamo a considerare ciò che unisce il tornitore di qualità con Lino Tagliapietra, perché questo mi sembra il primo vero quesito. In entrambi i casi abbiamo una situazione di forte soggettività all’interno di un mestiere in cui non mi limito a eseguire e ripetere un lavoro secondo canoni tradizionali, ma ci metto del mio. Questo “mio” può significare tante cose. Posso essere un inventore in pectore, che si diverte a trovare nuove soluzioni tecnologiche, nuovi modi di lavorare, o posso essere uno che sperimenta nuovi materiali, o ci mette qualcosa di artistico, ci mette un gusto estetico. Queste operazioni hanno a che fare con la quota di soggettività che uno mette nel suo lavoro, un lavoro che gli permette di capire a che cosa sta lavorando, perché altrimenti sarebbe un operaio. Questo mi sembra il punto, poi le declinazioni potranno anche essere diverse, e pienamente legittime. Invece un elemento di novità è che questa soggettività, questa voglia di metterci del proprio, si devono oggi sommare con una certa imprenditorialità, cioè con la volontà di assegnare valore economico nel tempo a questo esercizio, a questo sforzo».
Sempre considerando le diverse figure in cui s’incarna lo spirito artigiano, che cosa rappresenta quella del modellista, cui lei dedica diverse pagine, e come opera in un campo oggetto di una profonda trasformazione?
«Devo dire che il modellista è una delle figure che più mi affascinano, perché è una figura lungamente sottovalutata, mentre oggi ci rendiamo conto che rappresenta uno snodo fondamentale all’incrocio tra il processo creativo e le attività manifatturiere. Perché dico questo? Perché negli ultimi vent’anni noi abbiamo ritenuto che l’innovazione fosse qualcosa che aveva a che fare coi simboli, col pensiero, con la manipolazione dei concetti, mentre ciò che stiamo scoprendo è che questa attività di innovazione non può non confrontarsi con una dimensione materiale, del fare, della pratica, e che questo esercizio, questa contaminazione richiedono competenze specifiche che in realtà sono anche fonti di nuova conoscenza, nuovi ispirazioni, nuove riflessioni. A lungo abbiamo ritenuto che questa azione di collegamento fosse uno sforzo banale. Mentre banale non è, anzi è strategico, per moltissime realtà, ed è una attività in cui si esercita una creatività particolare: non una creatività che mette in primo piano la condizione soggettiva; magari la lascia un po’ sullo sfondo, ma non per questo risulta meno importante».
Oggi si parla molto di makers digitali, di start up innovative: lei cosa ne pensa? Utilizza il concetto di makers digitali come suggestione per suggerire un nuovo approccio alla figura dell’artigiano?
«È semplicemente la scoperta, avvenuta negli Stati Uniti, di qualcosa che in Italia conosciamo da tempo, cioè che dietro il lavoro artigiano ci sta anche una quota, mi lasci dire, di sovversione, no? Noi abbiamo sempre associato la figura dell’artigiano al custode della tradizione – che poi non era vero – ma se andiamo a vedere i successi dei Made in Italy nella cosiddetta Terza Italia, questi artigiani sono stati prima di tutto dei veri innovatori, anche sorprendenti. Ma il punto oggi è che questo specifico tipo di innovazione, che parte da un fare e passa attraverso le nuove tecnologie, può essere più efficace, più istruttivo di tanti centri di ricerca e sviluppo di multinazionali consolidate. Questo è un po’ il tema dei makers: è l’idea che dietro il saper fare ci sia una carica rivoluzionaria, che può trasformare le regole del gioco in molti settori della nostra economia. L’abbiamo già sperimentato, proprio sulla nostra pelle: pensiamo alla rivoluzione del design in larga parte riconducibile alle piccole imprese, in Lombardia o nel Veneto, no? Una rivoluzione che oggi passa soprattutto attraverso le nuove soluzioni chiamate di manifattura digitale. La stampante 3D, la produzioni col laser, le nuove macchine a controllo numerico».
Lei ha citato il Made in Italy. La rappresentazione più ingegnosa dell’artigianato, per quanto ci riguarda, è stata legata al Made in Italy e ai quattro ambiti produttivi in cui si è tradizionalmente espressa: agroalimentare, abbigliamento, arredamento, metalmeccanico. Sarà ancora così o assisteremo a inattese trasformazioni? Il Made in Italy continuerà a essere un fulcro delle diverse attività artigianali, in meccanica soprattutto, oppure quella è una stagione un po’ passata?
«Francamente credo che molte delle nostre competenze siano ancora lì e rimarranno lì. Però quello che oggi chiamiamo Made in Italy sarà sicuramente molto diverso. Faccio degli esempi: se guardo all’ibridazione fra design e tecnologie, penso a una nuova stagione per la domotica, per la nostra vita dentro la casa. Siamo pur sempre nell’ambito di arredo o meccanica, ma insomma in un contesto molto diverso. Penso a un mondo di macchine di nuova generazione che potrebbero trasformare completamente non solo la morfologia di alcuni settori industriali, ma addirittura il modo in cui pensiamo la divisione del lavoro.
Gli italiani potrebbero essere davvero campioni di queste cose, certo bisogna un po’ cambiare l’atteggiamento che abbiamo maturato in questi anni. Io leggo il giornale, guardo la tv e sento parlare di un inesorabile declino industriale legato anche a fatti drammatici, l’Ilva o il Sulcis, ma tutto questo riflettere e ragionare su problemi anche gravissimi che rappresentano in molti casi il passato della nostra industria, non ci deve, non ci può distogliere dalle opportunità che abbiamo di fronte e che costituiscono una delle poche leve su cui l’Italia può costruirsi un futuro».
Le facciamo una domanda sul suo ruolo di docente universitario: come dovranno o potranno cambiare i percorsi di formazione dei nuovi artigiani?
«Io posso dire come cambiano i percorsi formativi di chi studia economia aziendale. Noi dobbiamo assolutamente spiegare ai nostri giovani che quello che a lungo abbiamo considerato un retaggio del passato può rappresentare uno degli ingredienti di massima vitalità e competitività del nostro sistema di imprese. Non dobbiamo limitarci a una generica osservazione da lontano, ma dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi capiscano veramente ciò di cui stiamo parlando, abbiano la possibilità di immergersi in queste realtà senza percepirle come un passo indietro nel loro iter professionale, ma come un passo avanti, una grande opportunità. Fino a venti o trenta anni fa i giovani ci vivevano in questi ambienti, in queste aziende, nei loro laboratori. Oggi questo in molti casi non è più vero, mentre i giovani avrebbero tutto l’interesse di riappropriarsi di un tesoro di saper fare che può davvero rappresentare un plus nella loro carriera, innanzi tutto per quelli che entrano nelle aziende manifatturiere. C’è una nuova saldatura da stringere, è una bella sfida».
Quali considera elementi fondamentali di quello che potremmo chiamare lo spirito artigiano?
«Sono fondamentalmente tre. In primis un’idea profonda di autonomia, che significa il controllo del complesso processo di attività che rientrano in una dinamica del fare. Quindi un’idea di relazione, che mi sembra importantissima: io so per chi sto lavorando, lo conosco, so i suoi gusti, conosco le sue richieste, lo rappresento davanti a me, no? Che sia un cliente industriale o che sia un cliente domestico, io so chi è. Il terzo aspetto chiave della cultura artigiana è la riconoscibilità dei saperi e delle pratiche, che riguardano il fare all’interno di una dinamica sociale. Uno dice: io sono tornitore. Ciò non significa semplicemente fare certe cose, ma un’attività che ha anche una sua deontologia professionale, ha un suo modo di porsi di fronte ai problemi, e rispetto agli altri. Ecco: autonomia, relazioni e riconoscibilità sociale sono le tre chiavi del lavoro artigiano più o meno imprenditoriale, più o meno sovversivo».
Chi è Stefano Micelli
Stefano Micelli…